|


|
|
Un punto di
partenza per una libera discussione
PUNTI
DI VISTA
04/04/2001
Speranza a idrogeno?
Le
ricorrenti crisi petrolifere hanno quantomeno un pregio (se
consideriamo, realisticamente, solo fatti episodici le domeniche
senz’auto in città che “illuminate” amministrazioni comunali
propinano ogni tanto ai loro concittadini): quello di riaccendere
il dibattito sulle energie alternative. Lo scrivente, da sempre
incapace di rinunciare all’utopia, vent’anni fa esponeva pannelli
fotovoltaici in fiere locali, suscitando indubbia curiosità
da parte dei visitatori. Curiosità, e basta. E risultati non
esaltanti diede l’iniziativa dell’Enel, che finanziava una parte
dell’investimento neccessario ad installare, nel giardino o
sul tetto di casa, collettori solari per la produzione di acqua
calda. Ha pesato, indubbiamente, l’inerzia legata all’avvio
di segmenti di mercato nuovi, e alternativi all’esistente; in
particolare in Italia, perché sono ben note situazioni extraeuropee
ed europee in cui l’energia solare e quella eolica hanno trovato
tutt’altra accoglienza: Israele e Danimarca, ad esempio, rappresentano
realtà significative di paesi che hanno spinto l’acceleratore
della ricerca e delle applicazioni in questo campo, finché il
solare nel primo e l’eolico nel secondo sono divenuti voci insostituibili
(anche percentualmente) della produzione energetica nazionale.
E molto interessante è l’esperienza giapponese nelle celle a
idrogeno, che ha portato a realizzare in Estremo Oriente centrali
da alcuni megawatt. Difficoltà molto inferiori, tuttavia, ha
incontrato il decollo delle tecnologie telematiche su cui è
sorta la new economy. Non entriamo nel merito delle motivazioni
economiche alla base dei due fenomeni, suscettibili di notevoli
approfondimenti, per cui si rimanda ad altro editoriale. Qui
si vuole esplorare, un po’ più in dettaglio, il sentiero italiano
al “piccolo idrogeno”, come può definirsi la tecnologia delle
celle a idrogeno o celle a combustibile, in contrapposizione
(ma solo quantitativa) al “grande idrogeno” delle centrali nucleari
a fusione di deuterio e trizio, che dell’idrogeno sono isotopi
(tecnologia acquisita a tutt’oggi solo a livello sperimentale).
Nella fattispecie, anche noi abbiamo una centrale, all’interno
del tessuto urbano milanese, realizzata con celle a idrogeno
(non inquinanti e non più avveniristiche, nei fatti): quella
della Bicocca, area ex Pirelli (zona Lambrate), che rifornisce
di qualche megawatt il popoloso quartiere. Ma come funziona
la cella a idrogeno? A livello teorico la cella a idrogeno è
un generatore elettrochimico in cui entrano l’idrogeno (il combustibile)
e l’ossigeno (l’ossidante); la cella fornisce in uscita corrente
elettrica continua, acqua e calore. Come una comune pila, la
cella a combustibile è costituita da due elettrodi, anodo e
catodo, e da un elettrolita (in questo caso polimero) che rende
possibile il passaggio degli ioni, cioè atomi non più neutri
perché caricati positivamente o negativamente (vedi figura).
La similitudine si ferma qui. L’idrogeno fluisce verso l’anodo
di platino, dove libera elettroni, lasciando ioni di carica
positiva o cationi; gli elettroni passano nel circuito elettrico
esterno, mentre i cationi si diffondono attraverso l’elettrolita.
L’ossigeno è a contatto con il catodo, dove gli elettroni si
combinano con gli ioni idrogeno e con l’ossigeno, formando acqua
come residuo del processo. Anodo e catodo sono separati dall’elettrolita,
che costituisce lo strato centrale polimerico, e sono porosi,
al fine di alimentare le due reazioni fondamentali della cella:
l’ossidazione dell’idrogeno e la riduzione dell’ossigeno. Tra
l’anodo e il catodo si preleva la corrente elettrica continua
che fluisce nel circuito esterno, come in una pila tradizionale.
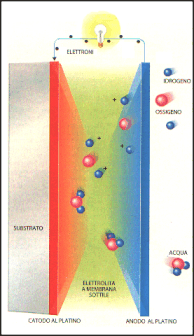 |
|
Cella a combustibile
|
Oltre
all’acqua, si hanno gas esausti da rimuovere come residui del
processo: né l’acqua, né i gas esausti contengono inquinanti,
e ciò costituisce uno degli aspetti più interessanti di questa
tecnologia. Dal punto di vista storico, la nascita (teorica)
delle celle a idrogeno risale al 1839, ad opera del fisico britannico
William R.Grove. Ma la prima realizzazione pratica si ha negli
anni ’60, quando la NASA ne costruì alcune versioni leggere,
da installare sui veicoli spaziali. Ai nostri giorni le celle
a idrogeno sembrano suscettibi-li di aprire nuovi varchi nella
propulsione di automobili e scooter elettrici, nella generazione
domestica di energia, nell’alimentazione di telefoni cellulari
e computer portatili. Occorre fare però alcune precisazioni,
centrate sul ruolo dell’idrogeno come futuro, ipotetico sostituto
del petrolio. Sono, purtroppo, molto attuali le avvisaglie dei
disastri imputabili all’effetto serra, causato principalmente
dalle emissioni di anidride carbonica: l’alluvione nel Nord-Est
italiano dell’autunno 2000 rischia di essere uno dei drammatici
eventi anticipatori dei cambiamenti mondiali del clima. Per
abbattere l’effetto serra è imperativo limitare l’uso dei combustibili
fossili: carbone, petrolio, e derivati del petrolio. In quest’ottica,
il ricorso all’idrogeno si presenta, almeno sulla carta, come
la grande chance energetica, da giocare in fretta. Volendo schematizzare,
tre sono le principali direttrici legate all’impiego dell’idrogeno:
-
Centrali nucleari a fusione di deuterio e trizio (isotopi dell’idrogeno):
ad oggi solo sperimentali, si prevede che diventino la principale
risorsa energetica mondiale, ma non prima degli ultimi decenni
del secolo.
- Motori a scoppio per autoveicoli, utilizzanti idrogeno al
posto della benzina: si tratta di un argomento antico, supportato
da lunga sperimentazione e indubbi risultati, che tuttavia non
sono mai approdati, in modo significativo, a livello commerciale.
-
Cell |